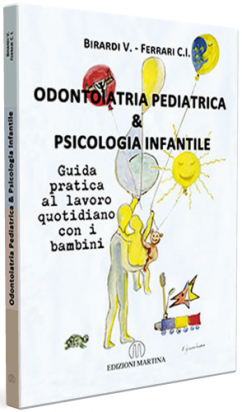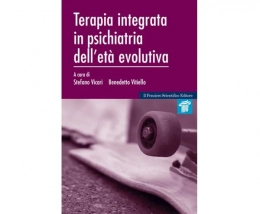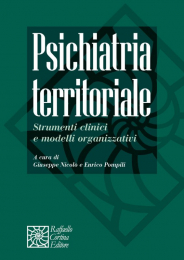Prefazione
1 - Perché parlare di psicologia infantile
1.1. Introduzione
1.2. Perché parlare di psicologia infantile
2 - Cenni storici, scoperte e definizioni
2.1. Cenni storici: scoperte e definizioni
2.2. L’interpretazione del disegno infantile
3 - Lo sviluppo cognitivo (dott. Andrea Maragliano)
3.1. Cenni storici delle teorie sullo sviluppo cognitivo
3.1.1. Il comportamentismo
3.1.2. Il costruttivismo di piaget
3.1.3. I neo-piagetiani: vygotskij
3.1.4. I neo-piagetiani: bruner
3.1.5. Il cognitivismo e la teoria delle intelligenze multiple di gardner
3.1.6. Nuove frontiere: approccio connessionista e neuroscienze cognitive
3.2. Pratica quotidiana
3.2.1. Il setting
3.2.2. L’adulto
3.2.3. Il pensiero
3.2.4. Il linguaggio
3.2.4.3. Perché le favole funzionano
4 - Stili genitoriali e teoria dell’attaccamento
4.1. Gli stili genitoriali
4.2. La teoria dell’attaccamento
4.3. I genitori e la visita pedodontica dei loro figli
5 - La paura dentale
5.1. La paura dentale
5.2. Chi ha paura e perché
5.3. L’empatia
5.4. Il bambino che ha paura si muove o sta fermo?
6 - La Psicosomatica (dott.ssa Claudia Y. Finocchiaro)
6.1. La storia della psicosomatica: dalle origini ad oggi
6.2. La psicosomatica nella prima infanzia
6.3. Vertici di attenzione psicosomatica
6.4. Tecniche psicosomatiche per la gestione dei bambini
6.4.1. Le tecniche cognitivo immaginative
6.4.2. Le tecniche fisiche
7 - Le tecniche usate in odontoiatria per la gestione del comportamento.
7.1. Il tell-show-do
7.1.1. L’avvicinamento progressivo del tsd
7.2. Il rinforzo positivo
7.3. Il controllo della voce
7.4. La distrazione
7.5. La comunicazione non-verbale
7.6. Presenza/assenza del genitore
8 - La gestione psicologica dell’anestesia locale
9 - La gestione psicologica della sedazione con miscela protossido d’azoto/ossigeno
9.1. Perché parlare di sedazione?
9.2. La sedazione procedurale
9.3. Il protossido d’azoto
9.4. Selezione del paziente
9.5. Perché pensare di sedare un bambino con la miscela di protossido d’azoto/ossigeno
9.6. Materiali e metodi
10 - Gli adolescenti, una relazione difficile
10.1. Il mondo dell’adolescenza
10.2. Aspetti critici per la professione odontoiatrica
10.2.1. Come vivono l’esperienza odontoiatrica gli adolescenti?
10.2.2. Come relazionarsi con l’adolescente
10.2.3. Come riconoscere quando un adolescente abusa di sostanze stupefacenti
10.3. Punti di forza e punti di debolezza degli adolescenti
10.3.1. I punti di debolezza degli adolescenti
10.3.2 I punti di forza degli adolescenti
10.4. Aspetti psicosociali dell’adolescenza e cure odontoiatriche (linee guida)
11 - La musica nello studio di odontoiatria infantile (dott.ssa Giovanna Canepa, dott.ssa Francesca Pasini)
11.1. La percezione sensoriale del feto
11.2. Come abbiamo ascoltato durante la nostra vita prenatale?
11.3. Il canto prenatale, vero dialogo con il bambino
11.4. Importanza del ritmo e impronta sonora
11.5. Dal prenatale al post fino allo studio odontoiatrico
11.6. I bambini crescono: che rapporto mantengono con i suoni e la musica?
11.7. Quale musica secondo la letteratura scientifica?
11.8. Come proporre la musica nello studio odontoiatrico
11.9. In conclusione
12 - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) e Autismo
12.1. Attention-deficit/hyperactivity disorder (adhd)
12.1.1. Come si interviene nell’adhd
12.2. I disturbi dello spettro autistico
12.2.1. La scoperta dell’autismo
12.2.2. Definizione e diagnosi
12.2.3. Eziopatogenesi
12.2.4. Prognosi
12.2.5. Comorbidità
12.2.6. Interventi non farmacologici e farmacologici
12.2.7. Riflessioni conclusive